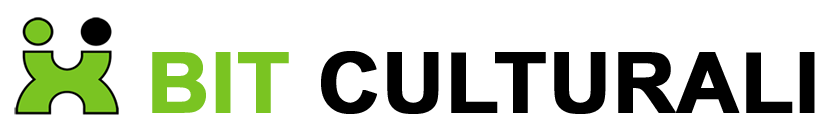Brassaï uscì dal caffè, girò l’angolo, continuò a camminare nell’oscurità parigina, quando… Che vide? Sul ciglio della strada comparve la figura di una prostituta nell’attesa di qualche cliente. “Paris de nuit” era anche questo.
Brassaï uscì dal caffè, girò l’angolo, continuò a camminare nell’oscurità parigina, quando… Che vide? Sul ciglio della strada comparve la figura di una prostituta nell’attesa di qualche cliente. “Paris de nuit” era anche questo.
L’occhio di Brassaï osserva, registra. Che siano intellettuali, artisti o clochard e prostitute, non fa differenza, ciò che conta è l’attimo, è la figura umana.
Spesso è stato definito un fotografo surrealista, ma l’artista ha sempre rifiutato questa precisazione. Si sentiva una specie di reporter, un occhio che coglieva la vita vera, per quanto questa potesse vestirsi di ombre. Già, perché guardando le sue immagini, la notte non sembra un tempo, ma un luogo; un luogo che ha a che fare indirettamente coi sogni e l’immaginazione: forse per questo le sue foto ricordano il surrealismo.
Diane Arbus, parlando ai suoi studenti, sosteneva che era stata “tormentata dalla chiarezza” fino a quando non era riuscita ad amare “veramente quello che non si può vedere nella fotografia. Una reale oscurità fisica…ed è elettrizzante l’oscurità”. Diane deve quest’attrazione soprattutto a Brassaï.
Infatti, nella foto Prostituée à l’angle de la Rue de la Reynie et Rue Quincampoix noi non vediamo la prostituta, se non la sua ombra. Ci verrebbe da chiedere come sia il suo volto, che età abbia, se sorride o è triste. Vorremmo quasi girare l’angolo, osservarla da vicino, parlarle e magari, se qualcuno ha qualche spirito missionario, provare a convincerla ad abbandonare la strada. Ciò che noi intravediamo è quello che possiamo intuire. La figura non tradisce una certa grazia, ma ciò è solo suggerita, non abbiamo i famosi specchi appesi alla parete che riflettono la realtà, possiamo servirci solo della nostra immaginazione, consapevoli che quell’ombra su un marciapiede illuminato di Parigi appartiene a tutti i tempi e a tutti i luoghi.
Le immagini possono avere delle rivelazioni profetiche, a volte, si possono nascondere in quelle ombre dei significati che solo il tempo potrà svelare.
Nella celeberrima foto di Talbot The Open Door – 1844, ciò che dà equlibrio e coerenza visiva all’immagine è il contrasto tra luce e ombra. Vediamo una porta socchiusa e una scopa poggiata sull’ingresso. Attraverso la porta solo ombre e oscurità, attenuate dalla luce che proviene da una finestra sul retro.
Quando Talbot scattò questa immagine era euforico, attratto dalla scoperta del mezzo fotografico.
Le porte in genere, come significato simbolico, sono il tramite tra ciò che si conosce e ciò che è ignoto. Jim Morrison, per spiegare il ruolo dei Doors, utilizzava una definizione analoga.
La porta socchiusa indica la speranza; la stanza, un luogo da esplorare, se solo si sposta la scopa. L’immagine simboleggia l’aspettativa, che la fotografia avrà negli anni, di entrare in territori inesplorati.
Talbot era così sicuro del nuovo mezzo artistico, da non porsi minimamente il problema della sua effettiva affermazione.
Ma qual è il territorio d’indagine della fotografia? La mera documentazione della realtà circostante, o anche i sentimenti e le aspirazioni interiori?
Cerchiamo di dire la nostra, servendoci ancora delle luci e delle oscurità.
Se provassimo a traslare i simboli di The Open Door verso i piani dell’indagine fotografica, individueremmo due territori separati da una porta socchiusa e ostacolati da una scopa posta lì quasi a separare il mondo esterno da quello interno.
La fotografia intesa come testimonianza del vero tende a prediligere un approccio documentario, la realtà diventa la sua riserva di caccia, ma se si entra nell’intimo di ciò che si fotografa, spostando idealmente la scopa di Talbot, l’indagine si muoverà tra le ombre di un mondo interiore e i significati saranno tutti introspettivi e dell’anima.
Attraversiamo la porta, lasciamoci guidare dalle ombre e potremmo trovarci in stanze oniriche e surreali. Su Bit Culturali, al prossimo appuntamento….
Diego Pirozzolo
Articoli correlati:
Dialogo con la fotografia. Nella notte di Brassaï
Bill Brandt, ai confini tra il reale e il surreale