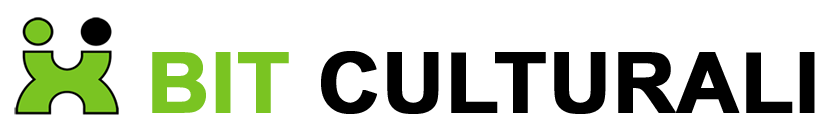Essere in cammino non è una cosa scontata, come sanno tutti quelli che, anche dopo una prima trionfale tappa a cavallo dei Pirenei, si sono visti costretti a fermarsi. Ne ho incontrati diversi lungo i miei precedenti cammini. Non trovare posto ed essere costretti a forzare per altri cinque o dieci chilometri può voler dire ritrovarsi, il giorno dopo, a zoppicare e scoprire, magari, che ci si è beccati un’altra tendinite o che il ginocchio non ne vuol più sapere. Mentre cammino si ripresentano di frequente punture di spillo e doloretti intorno al ginocchio, sui polpacci, sui tendini di Achille, sui piedi. E allora mi concentro sui miei passi, cerco di poggiare correttamente il tallone e la pianta, recito la preghiera del cuore mettendo a fuoco i punti in cui avverto dolore. E spero che la macchina regga, questa macchina che è il nostro corpo, che conosciamo così poco perché facciamo una vita così poco naturale. Una parte del godimento e della gioia di questa esperienza è legata alla sua componente fisica. La vita non è più costretta fra le stanze anguste di un appartamento, di una scuola, di un ufficio o di una fabbrica. La vita è finalmente dentro il nostro corpo, dentro di noi e sotto la volta del cielo, col sole e con la pioggia. Il tetto è necessario per il riposo ma non è sempre indispensabile.
Essere in cammino non è una cosa scontata, come sanno tutti quelli che, anche dopo una prima trionfale tappa a cavallo dei Pirenei, si sono visti costretti a fermarsi. Ne ho incontrati diversi lungo i miei precedenti cammini. Non trovare posto ed essere costretti a forzare per altri cinque o dieci chilometri può voler dire ritrovarsi, il giorno dopo, a zoppicare e scoprire, magari, che ci si è beccati un’altra tendinite o che il ginocchio non ne vuol più sapere. Mentre cammino si ripresentano di frequente punture di spillo e doloretti intorno al ginocchio, sui polpacci, sui tendini di Achille, sui piedi. E allora mi concentro sui miei passi, cerco di poggiare correttamente il tallone e la pianta, recito la preghiera del cuore mettendo a fuoco i punti in cui avverto dolore. E spero che la macchina regga, questa macchina che è il nostro corpo, che conosciamo così poco perché facciamo una vita così poco naturale. Una parte del godimento e della gioia di questa esperienza è legata alla sua componente fisica. La vita non è più costretta fra le stanze anguste di un appartamento, di una scuola, di un ufficio o di una fabbrica. La vita è finalmente dentro il nostro corpo, dentro di noi e sotto la volta del cielo, col sole e con la pioggia. Il tetto è necessario per il riposo ma non è sempre indispensabile.
A Pamplona, nel 2007, io e mia moglie ci siamo trovati a dormire sul verde, fra le case e le aiuole, un po’ per non aver trovato, un po’ per solidarietà con le giovani ungheresi e americane e il giovane sardo che abbiamo incontrato sull’autobus che ci aveva portati lì da Barcellona. Era Luglio, e il Cammino delle Stelle è cominciato per noi proprio così. Che strano, svegliarsi per strada e dirigersi verso la fontanella per le abluzioni del mattino! Sentirsi un po’ rotti ma, dopo qualche stiramento, accorgersi che, in fondo, la “macchina” riprende a funzionare. È una macchina viziata dalle mollezze e dalle pigrizie. Si lamenta un po’, all’inizio, ma poi ci restituisce un senso di rinnovato vigore.
A Samos, il dormitorio è freddo, ed io utilizzo tutto quello che mi sono portato prima di infilarmi nel sacco a pelo. Ho sempre litigato con quella zip. Ma stanotte, che davvero mi serve saperla utilizzare, mi riesce di chiudermi dentro al primo colpo. La felpa col cappuccio e il pigiama di lanella, a cui non ho saputo rinunciare, mi regalano una magnifica notte di riposo, anche se la mia branda è ad un passo dalla porta del bagno e, prima di addormentarmi, seguo il transito degli altri pellegrini e ascolto il caratteristico sfrigolio di buste di plastica tipico di questi dormitori .
 Il monastero ci ha anche offerto la possibilità di assistere ai vespri cantati dei monaci benedettini. Subito dopo, Raffaele, il medico che ho ritrovato, mi chiede di accompagnarlo alla messa delle 8 di sera. E così, la Domenica delle Palme finisce coll’essere doppiamente solenne.
Il monastero ci ha anche offerto la possibilità di assistere ai vespri cantati dei monaci benedettini. Subito dopo, Raffaele, il medico che ho ritrovato, mi chiede di accompagnarlo alla messa delle 8 di sera. E così, la Domenica delle Palme finisce coll’essere doppiamente solenne.
Prima di andare a letto, ci attende il menù del pellegrino, nel bar-mesòn di fronte all’ostello. Ci arrivo affamato come un lupo, con in circolo quel che resta delle banane e dei leches con café. Ennesima chiacchierata con Raffaele e anche la voglia di scambiare qualche sorriso con la brunetta che ci serve a tavola. Sacro e profano si intrecciano sul cammino come nella vita e ogni tentativo di separarli rigidamente è destinato a sconfinare nell’ipocrisia o nel ridicolo.
TERZO GIORNO
Il mattino dopo mi ritrovo nel bar con molte facce ormai note, con le quali continuo ad imbattermi da Triacastela. Uno di questi signori, alto e dinoccolato, con qualche apertura al posto dei denti e capelli grigi che scorrono scomposti sul collo (scoprirò ad Arzua che è di queste parti, anche se si accompagna a inglesi, olandesi e tedeschi), mi chiede di provare un formaggio locale che si sfarina come ricotta fra le mani. È lo stesso gesto di Ruben con la cioccolata, “Toma, toma…”, un gesto semplice che si ripete di continuo. E non solo da parte dei pellegrini del posto. Tutti i pellegrini diventano, sul cammino, fratelli e sodali, pronti ad aiutarsi e condividere la mensa o il cibo.
 Consumo il mio cappuccino con le Magdalenas o Sevillanas (piccoli pan di spagna dolci, imbustati, che si trovano nei bar e negli alimentari) nell’atmosfera fumosa del bar, do un’occhiata alla fotocopia della mia pagina della guida, quella che riguarda la tappa odierna, e mi avvio esitante verso la strada, continuando a fermarmi per fotografare il complesso monumentale del monastero, incrociando Jesus e parlando ancora con lui, osservando le finestre che spuntano dagli edifici un po’ alla maniera delle bay windows inglesi e il cielo grigio nero che non promette niente di buono.
Consumo il mio cappuccino con le Magdalenas o Sevillanas (piccoli pan di spagna dolci, imbustati, che si trovano nei bar e negli alimentari) nell’atmosfera fumosa del bar, do un’occhiata alla fotocopia della mia pagina della guida, quella che riguarda la tappa odierna, e mi avvio esitante verso la strada, continuando a fermarmi per fotografare il complesso monumentale del monastero, incrociando Jesus e parlando ancora con lui, osservando le finestre che spuntano dagli edifici un po’ alla maniera delle bay windows inglesi e il cielo grigio nero che non promette niente di buono.
Sotto questo cielo la pietra delle costruzioni assume un aspetto particolarmente severo, ma l’atmosfera della Galizia mi è ormai familiare e continuo, passo dopo passo, a farmi avvolgere dalla sua consistenza umida, muschiosa, liquida di fiumi, torrenti e sorgenti, e al tempo stesso solida e antica di pietre che sfidano il tempo, che coprono i tetti, che si ergono sui bordi dei campi a limitare i confini o si stendono le une sulle altre a comporre i muretti.
 Riprendo a costeggiare un fiume, passo affianco di un villaggio con una chiesetta in pietra ancor più piccola del solito, con appena una campanella che spunta sulla facciata e utilizzo la fermata coperta di un bus per attrezzare me e il mio zaino per la pioggia.
Riprendo a costeggiare un fiume, passo affianco di un villaggio con una chiesetta in pietra ancor più piccola del solito, con appena una campanella che spunta sulla facciata e utilizzo la fermata coperta di un bus per attrezzare me e il mio zaino per la pioggia.
Proseguo ancora sulla strada, in difesa del mio amato carretto, e lì dove il “camino” sembra ripresentarsi asfaltato fermo un automobilista per chiedere quali sono le condizioni del sentiero da quella parte. La risposta mi convince a proseguire sulla strada statale. È ancora la Lu633, quella iniziata a Pedrafita e segna il km 39.
È l’inizio del terzo giorno. Meno di 40 km di percorso. 5 ore per strada, il primo giorno, 7 il secondo. Ma prima di quel km zero ci sono stati i giorni passati in treno, aereo, autobus, per arrivare a Piedrafita. Prima ancora, la frenesia dei preparativi finali. Procedendo indietro, gli allenamenti in montagna. E prima ancora, le due esperienze estive, con l’identica sequenza di preparazione, anticipazione, confusione, fatica, sorpresa, preoccupazione, arrivi, gioia, ginocchia dolenti, paura, incontri, sorrisi, abbracci e anche pianti.
 Voglio dire che in quelle tredici ore mi sono ormai reinserito in un tempo che scorre parallelo al tempo della mia vita “normale” di questi ultimi tre anni. È il tempo di Vincenzo il Pellegrino, una vita separata e una storia diversa che si contrae o si dilata secondo il battito del cuore. Tornerà a scorrere sotterranea, carsica e invisibile, nei giorni indaffarati di sempre e a riproporsi come oggi, palpitante e infinita, come se fossi su questa strada dalla mia nascita o come se, in effetti, fossi nato qui, dai passi ripetuti sull’asfalto. A casa, mi accorgo di dover spiegare qualcosa che qui si svolge con estrema naturalezza. La vita è questa altalena fra la veglia e il sonno, fra una branda e un sentiero sterrato, un bar e una chiesa di pietra, il bastone che batte sulla destra, le ruote che cigolano sulla sinistra, il cappuccio che mi protegge dalle gocce, il vento che asciuga la mia camicia, un sorriso e un saluto con la mano, buen camino! buen camino! buen camino.
Voglio dire che in quelle tredici ore mi sono ormai reinserito in un tempo che scorre parallelo al tempo della mia vita “normale” di questi ultimi tre anni. È il tempo di Vincenzo il Pellegrino, una vita separata e una storia diversa che si contrae o si dilata secondo il battito del cuore. Tornerà a scorrere sotterranea, carsica e invisibile, nei giorni indaffarati di sempre e a riproporsi come oggi, palpitante e infinita, come se fossi su questa strada dalla mia nascita o come se, in effetti, fossi nato qui, dai passi ripetuti sull’asfalto. A casa, mi accorgo di dover spiegare qualcosa che qui si svolge con estrema naturalezza. La vita è questa altalena fra la veglia e il sonno, fra una branda e un sentiero sterrato, un bar e una chiesa di pietra, il bastone che batte sulla destra, le ruote che cigolano sulla sinistra, il cappuccio che mi protegge dalle gocce, il vento che asciuga la mia camicia, un sorriso e un saluto con la mano, buen camino! buen camino! buen camino.
È lunedì, giorno di chiusura per molti di quei bar-meson dove ci si può fermare per strada a mangiare qualcosa, riposare, scambiare due chiacchiere con l’oste o con gli altri pellegrini.
E così i posti che incontro servono solo per fare altre foto e guardarmi intorno, mentre la pioggia dà qualche sparuta tregua e riprende a picchiettare sulla mia giacca che chiamo a torto impermeabile, ma che scoprirò, a mie spese, non esserlo abbastanza.
Sperimento, lungo la strada che percorro in solitario, il conforto che mi dà quella sottile superficie contro la quale sbatte la pioggia. La mia casa è diventata quel cappuccio, la mia finestra i miei occhiali. Mi manca solo un tergicristallo miniaturizzato e sono costretto, ogni tanto, a fermarmi per pulire quei vetri che ormai mi lasciano solo intravedere il paesaggio circostante. Il sudore li appanna e la pioggia li annacqua. Camminare in queste condizioni è meno piacevole, ma è così che anche la Galicia mi è entrata nelle ossa, come la Castilla con il suo sole cocente e le sue distese di grano e la Rioja con le vigne e i grappoli che annunciavano un autunno ancora da venire, ma odoroso di mosti e d’uva matura.
Qualsiasi altro modo di viaggiare mi sembra ormai molto più vicino allo sguardo catatonico del telespettatore. Occhi distratti sui finestrini o sollevati sulle torri a rintracciare i fregi di cui parla la guida.
Io non guardo il paesaggio, ne faccio parte, come le pietre e la pioggia. L’unico gesto, che mi riporta nella posizione dello spettatore, è quello dell’estrarre la macchina fotografica. Ma quegli scatti mi aiuteranno a comporre queste note e a rientrare in quel tempo eternamente presente che è il tempo del pellegrino, dell’errante, del vagabondo. Una dimensione nella quale mi sento finalmente ed autenticamente vivo. E non c’è posto al mondo dove io mi sia sentito così a casa mia come su queste strade, in mezzo al popolo dei pellegrini.
Vincenzo Continanza
Segui il viaggio:
Prima tappa: In Galizia sul Cammino per Santiago di Compostela
Seconda tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Da O Cebreiro a Fonfria
Terza tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Verso il monastero di Samos
Quarta tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Il tempo del pellegrino
Quinta tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Verso Ferreiros
Sesta tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Arrivo a Hospital de la Cruz
Settima tappa: Sul Cammino di Santiago di Compostela tra ricordi e sogni
Ottava tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Compagni di viaggio
Nona tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Sosta a Casanova
Decima tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Arrivo a Ribadiso
Undicesima tappa: Cammino di Santiago di Compostela – 40 chilometri alla meta
Dodicesima tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Sosta a Santa Irene
Tredicesima tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Verso Monte do Gozo