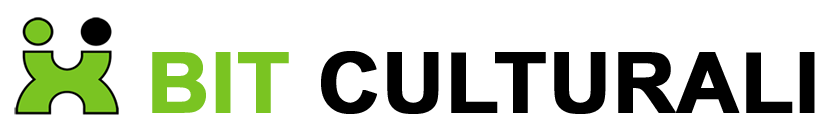Settimo giorno. Il mattino seguente, poco dopo le otto, sto ancora finendo di impacchettare e sento la voce della hospitalera che ci invita a lasciare al più presto il rifugio. Secondo le regole bisogna essere fuori per le otto, ma è la prima e unica volta che mi capita di sentire una hospitalera che ci metta fretta mentre ci stiamo preparando. Forse hanno premura di iniziare le pulizie perché il rifugio si è riempito completamente; anche questa è una prima volta, in questa settimana.
Faccio qualche foto prima di lasciare Santa Irene e imboccare il sentiero fra gli alberi.
Vi è capitato di attendere a lungo qualcosa? O di inseguirla? Quando, alla fine, la meta è vicina, può capitare di avvolgersi in un’altra contraddizione. Ci prende una specie di dispiacere; si ha nostalgia dei giorni in cui la si vedeva così lontana, così irraggiungibile da poterla trasfigurare in una nuvola di sogno.
Quest’ultima tappa, allora, voglio che sia la penultima, per potere allungare almeno di dodici ore l’ingresso nella città e nella Cattedrale di Santiago. Quando sarò a Monte do Gozo, sarò ormai in vista della città, ma mi fermerò su quel monte che è, in realtà, solo una collinetta, e dormirò lì, rimandando all’indomani il “gozo”, ossia il godimento, il piacere di cogliere il frutto delle proprie fatiche. Senza nascondermi quanto, di quelle fatiche, siano già state ampiamente diluite in una gran quantità di piaceri già goduti. Se è vero che il significato originario del pellegrinaggio è quello penitenziale, io ho voluto, nel corso di questa mia fatica, addolcirne le asprezze, concedendomi i piaceri del buon cibo e della compagnia, senza contare il piacere supremo di ricominciare, ogni giorno, a respirare a pieni polmoni sotto un tetto fatto di cielo e nuvole. Ogni mattina lasciarsi alle spalle la prigione di muri, sedie, tavoli e letti che, normalmente, chiamiamo case; fuori, all’aperto, nel vento e nella pioggia! Non più schermi di vetro chiamati finestre, luce elettrica e calore artificiale, ma il calore del proprio corpo in movimento, la luce diffusa del sole, che splenda o si nasconda fra le nuvole, e le congiuntive arrossate degli occhi aperti sul mondo, spalancati per lo stupore.
Era proprio necessario arrivare fin qui per fare quello che chiunque può fare uscendo dalla propria casa? No, ovviamente no. Ma qui la strada è già tracciata e, in un certo senso, non bisogna inventarsi nulla, basta seguire le tracce già impresse sul terreno e le voci che risuonano nell’aria. Di colpo si è trascinati in una corrente che attraversa i secoli e il tempo, non solo lo spazio che separa i campanili e gli abitati. Se avessero inventato qualche detector in grado di misurare l’energia che ognuno di noi lascia dietro di sé lungo questo percorso, sono convinto che se ne potrebbe qui verificare il funzionamento. Mi pare di vedere quelle lancette impazzire, come quelle di un geiger in prossimità di una fonte di radioattività. Ecco perché venire fino qui: per immergersi nella corrente che travolge anche la nostra pigrizia e le nostre paure.
 Leggo sul cippo di pietra la cifra 19,5. Anche i 20 sono alle spalle, Santiago è alla portata di una mia giornata di cammino; non è mai stata così vicina. In corrispondenza di questo segnale, incrocio una coppia di sudamericani, lui appassionato di foto, che mi ritrae da tre angolazioni diverse. Porta intorno al collo una macchina fotografica reflex, non la solita digitale, ed è l’unico che abbia incontrato con una apparecchiatura così ingombrante. Continua a fare su e giù per riprendere la moglie e il sentiero, seguendo la sua ispirazione, e sembra un fotoreporter più che un pellegrino. Si chiama Diego e, per ricordarmelo, lo associo al Diego de la Vega del telefilm di Zorro. Anche lo scorso anno mi sono imbattuto in una coppia di sudamericani del Nicaragua. Hanno in comune con loro una certa freschezza di spirito, qualcosa di ingenuo e di autentico che li distingue dalla media degli europei. Mi parlano dei loro progetti, degli studi completati e di quelli che ancora vorrebbero intraprendere, della difficoltà di ricongiungersi e ottenere il permesso di lavoro, dell’anno trascorso lontano l’uno dall’altra, lei a studiare negli Stati Uniti, lui in Africa per un progetto a sostegno delle popolazioni locali, dell’idea di trascorrere un periodo in Francia per imparare bene la lingua.
Leggo sul cippo di pietra la cifra 19,5. Anche i 20 sono alle spalle, Santiago è alla portata di una mia giornata di cammino; non è mai stata così vicina. In corrispondenza di questo segnale, incrocio una coppia di sudamericani, lui appassionato di foto, che mi ritrae da tre angolazioni diverse. Porta intorno al collo una macchina fotografica reflex, non la solita digitale, ed è l’unico che abbia incontrato con una apparecchiatura così ingombrante. Continua a fare su e giù per riprendere la moglie e il sentiero, seguendo la sua ispirazione, e sembra un fotoreporter più che un pellegrino. Si chiama Diego e, per ricordarmelo, lo associo al Diego de la Vega del telefilm di Zorro. Anche lo scorso anno mi sono imbattuto in una coppia di sudamericani del Nicaragua. Hanno in comune con loro una certa freschezza di spirito, qualcosa di ingenuo e di autentico che li distingue dalla media degli europei. Mi parlano dei loro progetti, degli studi completati e di quelli che ancora vorrebbero intraprendere, della difficoltà di ricongiungersi e ottenere il permesso di lavoro, dell’anno trascorso lontano l’uno dall’altra, lei a studiare negli Stati Uniti, lui in Africa per un progetto a sostegno delle popolazioni locali, dell’idea di trascorrere un periodo in Francia per imparare bene la lingua.
Dopo soli tre chilometri siamo a Pedrouzo, dove sarei dovuto arrivare il giorno prima. Ed è il primo bar e la prima sosta di quest’ultima tappa. Il bar è pieno di “colleghi” seduti ai tavoli e al banco. Ci sediamo anche noi per la colazione e poi ci separiamo; io alla ricerca di una farmacia che mi indicano in direzione opposta al tracciato del cammino. La farmacia è chiusa e per scoprirlo, fra andata e ritorno, arrotondo il percorso di oggi di un paio di chilometri. Poco male, si tratta comunque di una tappa facile. Il carrito procede sulla pista di terra, fango e foglie di eucaliptus e, ogni tanto, devo liberare una ruotina che si inceppa. Al chilometro 15 sono ad Amenal. Dopo pochi minuti il sentiero incrocia la strada asfaltata. Poi mi addentro ancora nella vegetazione che crea una specie di galleria verde. Sono a Cimadevila al chilometro 14 e percorro le ultime salite lungo sentieri pietrosi e fra i boschi, prima di uscire all’aperto in prossimità di un grosso svincolo stradale. Prima di raggiungerlo sento il rombo di un aereo, alzo la testa e inquadro il velivolo. Sono vicino all’aeroporto di Santiago. Il sentiero scorre a fianco della strada e poi si ritira ancora fra gli alberi, vicino a un ruscello dalle acque arrossate per i residui ferrosi che trasporta. Attraverso la strada asfaltata e passo su un andadeiro che volta verso destra. Le campane di una chiesa nascosta dietro un bel casolare dai muri di pietra e una piccola folla di pellegrini mi segnalano che sono a Sanpaio. Ritrovo Diego e la moglie, seduti a un tavolino, fuori del bar. Li saluto e mi diverto a dare qualche mollichina a un gatto che si aggira fra le sedie. Nel bar che porta il nome di Porta de Santiago e il titolo di Casa de Comidas mi faccio tagliare una fetta di queso manchego. Qualche foto al casolare e alla chiesina con le due campane e proseguo deciso verso Labacolla, la località da cui prende il nome l’aeroporto. Era il luogo dove, anticamente, i pellegrini si lavavano a un ruscello e cercavano di darsi un aspetto presentabile, prima di avvicinarsi alla tomba dell’apostolo. Di qui il nome, che allude all’atto di lavarsi il collo e, presumibilmente, almeno le mani e la faccia.
 Un cippo con la conchiglia del cammino di colore giallo su fondo blu porta un numero disegnato con vernice a spruzzo: 11. È l’ultima indicazione della distanza da Santiago che incontro. Una chiesa porta incisa la data di costruzione, 1840 , e il nome di chi ha sostenuto le spese, un certo Don Francisco Rodriguez Abella. Sulla scalinata di fronte la chiesa una famiglia, che comprende anche nonno e nipoti, sta facendo una pausa e qualcuno si offre di scattarmi una foto. Non è successo quasi mai che abbia dovuto chiederlo, sono sempre altri che, vedendomi da solo, mi chiedono se voglio essere ritratto. Dopo aver approfittato di una cabina telefonica per chiamare a casa, la mia marcia continua. Incrocio di nuovo la statale e attraverso il ruscello che, in passato, deve aver consentito le abluzioni dei pellegrini. Si avvicina una ragazza sorridente, Anja, di nazionalità polacca e in Spagna per motivi di studio. Chiacchieriamo un po’ mentre superiamo una leggera salita. La ruotina sinistra del carrito si inceppa e devo fermarmi per liberarla dal fango che la intralcia. Quando mi rimetto in corsa e incontro di nuovo Anja, vuole farmi una foto e anch’io faccio lo stesso. Si fermerà in un rifugio che conosco già e mi invita a passare a trovarla.
Un cippo con la conchiglia del cammino di colore giallo su fondo blu porta un numero disegnato con vernice a spruzzo: 11. È l’ultima indicazione della distanza da Santiago che incontro. Una chiesa porta incisa la data di costruzione, 1840 , e il nome di chi ha sostenuto le spese, un certo Don Francisco Rodriguez Abella. Sulla scalinata di fronte la chiesa una famiglia, che comprende anche nonno e nipoti, sta facendo una pausa e qualcuno si offre di scattarmi una foto. Non è successo quasi mai che abbia dovuto chiederlo, sono sempre altri che, vedendomi da solo, mi chiedono se voglio essere ritratto. Dopo aver approfittato di una cabina telefonica per chiamare a casa, la mia marcia continua. Incrocio di nuovo la statale e attraverso il ruscello che, in passato, deve aver consentito le abluzioni dei pellegrini. Si avvicina una ragazza sorridente, Anja, di nazionalità polacca e in Spagna per motivi di studio. Chiacchieriamo un po’ mentre superiamo una leggera salita. La ruotina sinistra del carrito si inceppa e devo fermarmi per liberarla dal fango che la intralcia. Quando mi rimetto in corsa e incontro di nuovo Anja, vuole farmi una foto e anch’io faccio lo stesso. Si fermerà in un rifugio che conosco già e mi invita a passare a trovarla.
Il sentiero si è ormai trasformato in una stradina asfaltata e siamo alla periferia della città. Come mi aveva avvisato la pagina della guida che porto con me, passo davanti alla sede della TV galiziana e al camping San Marco. Vedo ancora Diego e la moglie seduti sul bordo della strada, lui impugna la sua macchina fotografica per riprendere due signori a cavallo, che procedono in direzione opposta. Pochi metri più avanti c’è un club ippico e, vicino all’entrata, una indicazione sistemata su due pali di ferro che recita “Monte do Gozo …be..gue peregrinos” . Quanto basta per capire che sono vicino all’albergue di Monte do Gozo, ormai alla fine del mio pellegrinaggio. Quella di domani sarà una passeggiata, più che una camminata. Sull’ultima salita supero comitive di signore e gruppi di adolescenti; probabilmente turisti che si divertono a percorrere gli ultimi chilometri a piedi, mentre qualche autobus li attende a Santiago.
 Sono le due del pomeriggio mentre attraverso il piccolo centro di San Marco, che prende nome dall’omonima cappellina intitolata all’evangelista. Le gambe potrebbero portarmi tranquillamente fino al centro della città, ma resto fedele al programma stabilito. Passo di fronte al moderno monumento che ricorda la visita di Giovanni Paolo II, nel 1993, anno a partire dal quale questa antica tradizione ha ripreso slancio, per diventare, dal 1999, un fenomeno di massa.
Sono le due del pomeriggio mentre attraverso il piccolo centro di San Marco, che prende nome dall’omonima cappellina intitolata all’evangelista. Le gambe potrebbero portarmi tranquillamente fino al centro della città, ma resto fedele al programma stabilito. Passo di fronte al moderno monumento che ricorda la visita di Giovanni Paolo II, nel 1993, anno a partire dal quale questa antica tradizione ha ripreso slancio, per diventare, dal 1999, un fenomeno di massa.
Ho qualche esitazione su dove trovare il rifugio ma, alla fine, una breve scalinata mi porta alla prima di una serie di camerate disposte, una di fronte all’altra, lungo una ampia discesa pavimentata. Mi fa pensare al centro residenziale di un campus universitario.
Mi registro e pago, mi viene assegnato un numero che è quello della mia camera, una camera da otto letti, una delle molte disposte lungo il corridoio. In totale, ogni rifugio può contenere più di cento pellegrini. Disfatto lo zaino e dopo una sosta nei bagni, provvisoriamente a corto di acqua calda , mi reco in cucina dove un italiano pittore e poliglotta si siede insieme a una biondissima vichinga di Hannover, che ho già incontrato a Santa Irene e a Pedrouza. Io, col mio pezzo di formaggio, e l’italiano, con piattoni di ceci e insalate varie, ci ritroviamo a mangiare e discorrere. In un angolo del piano cucina contrassegnato con la scritta “para todo el mundo” (per tutti) trovo una bella insalata di pasta ben condita alla quale aggiungerò un bel po’ dei ceci dell’italiano. Di lui non ricordo il nome, ma mi fa pensare a un curioso signore francese incontrato la scorsa estate. Magro come lui e con una luce un po’ febbrile nello sguardo. Mi racconta di essere qui da un po’ e di voler restare ancora. Ogni giorno, quando non piove, va alla cattedrale e si mette a dipingere. È, dunque, uno degli artisti di strada che si incontrano nei pressi della cattedrale. Ricordo i suonatori di gaita, la cornamusa galiziana, e un gruppo che esegue un repertorio classico, adattato per flauto e chitarre. La tedesca si chiama Anika, sorride e, ogni volta che le si offre qualcosa da mangiare risponde “…may be”, con una strana espressione del viso, un po’ stupita e un po’ divertita. Non è ancora avvezza alla comunicativa facile e spontanea dei pellegrini e degli italiani; accetta, ma con riserva, quello che le viene offerto, quasi temendo che dire semplicemente “yes” la possa compromettere. Poi arriva un gruppo di giovani adolescenti che invadono il tavolone. Non sono particolarmente lieto del loro arrivo, ma poi scopro che ceci, patate, salsicce e tutto il ben di Dio, è roba loro e che lo mettono a disposizione di tutti i presenti. Un signore dalla lunga coda di capelli li invita a lasciare spazio anche per gli altri. Mi pare un insegnante o una guida turistica e poco dopo scopro che è, invece, un sacerdote salesiano. Alle cinque e mezza del pomeriggio mi trovo nella cappellina e li rivedo tutti lì, che preparano una celebrazione della notte di Pasqua anticipata al pomeriggio, per consentire a tutti di riposare e proseguire, l’indomani, verso la cattedrale.
A parte i ragazzi, ci sono un paio di francesi appena arrivati, con lo zaino ancora in spalla e Gerard, il tedesco che mi racconterà di avere attraversato l’Italia a piedi, bussando alle porte dei parroci per le soste notturne, dalle Alpi a Roma e poi da Roma a Brindisi. È in pensione e trascorre 3 o 4 mesi all’anno viaggiando a piedi per l’Europa.
La celebrazione è ricca di simboli, come quello della luce, la luce del cero pasquale e poi quella delle candeline distribuite a tutti i presenti; ci sono i canti, la chitarra e la voce di una corista che spicca sulle altre.
È Pasqua, la meta è ormai vicina, il cammino continua a regalarmi incontri, allegria, voci, canti, occasioni di condivisione. La vita risorge, la morte è sconfitta, la tristezza è dimenticata. Nel cielo passano nuvole bianche e nere e soffia un vento fresco, ma la primavera riporterà la sua luce e i suoi cieli azzurri.
Questo pomeriggio, a differenza del precedente, è scivolato come l’olio, fra pranzo, chiacchiere, un po’ di sole fra le nuvole, un caffè procurato dal solito italiano, che qui conosce tutti e sa dove trovare quel che vuole; poi una passeggiata e la celebrazione in cappella.
Nel frattempo è tornata l’acqua calda ed è possibile fare la doccia che avevo rimandato. Quando rientro in cucina, la conversazione si allarga ad un altro italiano, Antonio di Modena. Sarà lui ad accompagnarmi il giorno dopo.
Vincenzo Continanza
Segui il viaggio:
Prima tappa: In Galizia sul Cammino per Santiago di Compostela
Seconda tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Da O Cebreiro a Fonfria
Terza tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Verso il monastero di Samos
Quarta tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Il tempo del pellegrino
Quinta tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Verso Ferreiros
Sesta tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Arrivo a Hospital de la Cruz
Settima tappa: Sul Cammino di Santiago di Compostela tra ricordi e sogni
Ottava tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Compagni di viaggio
Nona tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Sosta a Casanova
Decima tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Arrivo a Ribadiso
Undicesima tappa: Cammino di Santiago di Compostela – 40 chilometri alla meta
Dodicesima tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Sosta a Santa Irene
Tredicesima tappa: Cammino di Santiago di Compostela – Verso Monte do Gozo