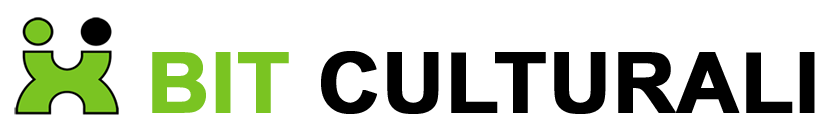La prima impressione che un film come Ma Loute suscita nello spettatore – quantomeno nello spettatore che non ha avuto modo di vedere P’tit Quinquin, la miniserie poliziesca che Bruno Dumont ha realizzato nel 2014 per Arte – è lo sconcerto. Di fatto, Ma Loute individua, soprattutto sul piano espressivo, un deciso e inatteso cambio di direzione nell’itinerario artistico dell’autore. Si può cogliere uno scarto radicale, un repentino mutamento di scrittura tra la produzione del primo periodo del cineasta e questa sua prova più recente. Autore ormai acclamato di un cinema “difficile”, grave, ascetico, non spettacolare, capace di riflettere intorno a temi forti adottando una messa in scena di esemplare rigore e lucidità, Dumont rinuncia qui all’austerità linguistica di L’età inquieta o di Hadewijch a favore di un segno più brioso e sbrigliato, e più fluido, che consente alla narrazione di acquisire maggiore vivacità e scioltezza.
Sorretto da un’intonazione ferocemente provocatoria e beffarda, Ma Loute realizza una contaminazione tra generi diversi, dove i codici formali della commedia grottesca, sottoposti a continue rotture di tono e di registro, si ibridano con altri modelli, riconducibili di volta in volta all’universo del fantastico, del polar, dell’orrorifico, del mélo. Se il meccanismo acidamente umoristico su cui è imbastito il film asseconda una bizzarra vis comica di ispirazione slapstick (i ripetuti capitomboli dell’ispettore obeso), intessuta da una girandola di gag deliranti e di facezie stralunate, che raggiungono toni “eccessivi”, di farsa buffonesca, surreale, tale vena farsesca si contamina poi con crudezze e cupezze inquietanti, che virano talora verso il macabro. L’intenzione comica, il voluto rifiuto della verosimiglianza assecondano un’intenzione favolistica che non esclude i toni gravi, risentiti.
Va fatto notare come, per certi aspetti, Dumont resti anche qui fedele a se stesso. Le coordinate stilistiche a cui ha scelto di far ricorso sono state totalmente rinnovate, è vero, ma non sono cambiati i temi cari al cineasta, lo scenario, e soprattutto il paesaggio umano che il film mette in campo: un paesaggio segnato da un profondo malessere, non toccato dalla Grazia, verso cui il regista sembra non provare alcuna accondiscendenza, quasi che in questa occasione egli abbia inteso conservare un distacco gelido e inclemente dalle figure mostruose che va ritraendo.
I personaggi che popolano il film appaiono tanto caricati nelle loro magagne fisiche e morali da aver smarrito ormai ogni connotazione realistica e figurare semplicemente come marionette carnevalesche, fantocci meccanici, al limite del subumano (la recitazione di Luchini mira ad accentuare il lato caricaturale del suo personaggio ricorrendo a movenze legnose). Se allora i membri dell’agiata famiglia altoborghese in villeggiatura sulla costa d’Opale ostentano gli istrionismi e gli isterismi, la frivola sicumera, dietro cui si maschera l’ottusità congenita di una classe in pieno disfacimento, i corpi terrigni e animaleschi del clan di pescatori indigeni dediti al cannibalismo assumono forme grottesche e mostruose. A completare il quadro, v’è un’improbabile coppia di goffi e ridicoli poliziotti, la cui catastrofica inadeguatezza professionale mira a riassorbire la sottotrama “gialla” entro una cornice comico-demenziale.
Per contro, la figura angelicata di Billie, forte del fascino ambiguo che emana dalla sua incerta identità sessuale (è una ragazza che si veste talora da uomo o un ragazzo che finge di essere una donna?), diviene nel film l’immagine di un’androginia misteriosa, enigmatica, capace essa sì di sottrarsi ai vincoli e alla logica predatoria dell’ordine familiare e di classe per affermare la propria diversità scandalosa entro cui le distinzioni di sesso e natura sono venute a mancare. L’amore impossibile che nasce tra Billie e Ma Loute è destinato inevitabilmente a creare disagio in chi, riconoscendo in esso il rifiuto eversivo delle barriere e dei pregiudizi che separano due gruppi sociali considerati inconciliabili, lo percepisce come un gesto di sfida nei confronti di un mondo degradato a cui non è concessa alcuna possibilità di redenzione.
Sarebbe in ogni caso un errore accordare al film intenzioni ideologiche che non gli competono. Dumont, qui come altrove, non appare interessato a illustrare i problemi economici del Nord della Francia, o a riproporre logori schematismi manichei sulla lotta di classe. Ma Loute esibisce piuttosto il tema dell’identità “altra” e irriducibile, di cui l’apparizione di Billie si fa portavoce, come elemento salvifico atto a restituire al mondo la sua bellezza. Una bellezza che è là, nel luminoso paesaggio della costa d’Opale, sulle cui dune sabbiose si muovono – ciechi davanti a tanto incanto – i personaggi del film con i loro corpi goffi, sgraziati, contorti, deformi, simili alle figure grottesche di un quadro di Brueghel, smarrite esse pure entro uno scenario di lussureggiante splendore.
Dumont, che si è imposto questa volta di adottare un’impaginazione figurativa ambiziosa, ricorre a una fotografia stilizzatissima, giocata su impasti cromatici squillanti e a un décor spaesante (l’incredibile dimora in stile déco egiziano dei Van Peteghem) dove sono rintracciabili richiami alla pittura di Magritte.
Nicola Rossello
Scheda film
Titolo: Ma Loute
Regia: Bruno Dumont
Cast: Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Jean-Luc Vincent, Brandon Lavieville, Raph, Didier Desprès, Cyril Rigaux, Laura Dupré, Thierry Lavieville, Lauréna Thellier, Manon Royère, Caroline Carbonnier
Durata: 122 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Movies Inspired
Anno: 2016