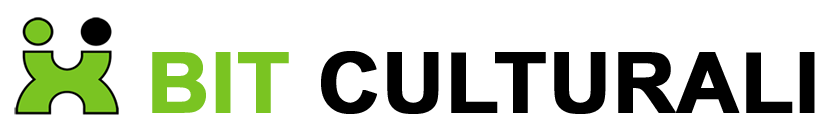Liberamente ispirato a un racconto di Haruki Murakami, Drive my car celebra la forza salvifica della parola, la capacità di ascolto e di comunicazione come strumenti atti a vincere l’ossessione del lutto, la solitudine, la rassegnazione, e ad aprire le porte alla speranza.
Il lungo prologo del film descrive il rapporto tra Yusuke e Oto: lui un affermato attore e regista teatrale, lei una sceneggiatrice che lavora per la televisione. Una coppia che, segnata dalla scomparsa della propria bambina, ha smesso di comunicare. Oto è ancora legata al marito, ma lo tradisce con un giovane attore. Yusuke viene a scoprirlo, ma sceglie di tacere. La donna muore improvvisamente a causa di un’emorragia cerebrale. Seguono i titoli di testa e una brusca ellissi temporale.
Sono trascorsi due anni. La storia ci porta a Hiroshima (la scelta del luogo non è casuale in un film che parla della necessità di elaborare il trauma). Qui Yusuke è stato chiamato ad allestire la messa in scena di uno Zio Vanja multilingue, con interpreti provenienti da Paesi diversi.
L’impegno professionale che egli esibisce nel dirigere le prove dello spettacolo maschera di fatto un senso di estraneità verso le cose e le persone, una solitudine profonda. L’uomo non è riuscito ad accettare la morte della moglie. Sottraendosi alla necessaria elaborazione del lutto, si è consegnato a un’esistenza spenta, senza gioia, dominata da una nera malinconia.
Decisivo per lui sarà allora l’incontro con Misaki, una giovane donna a cui, per ragioni assicurative, egli è costretto ad affidare la guida della propria automobile nei tragitti tra la residenza che gli è stata assegnata e il luogo di lavoro.
La vettura in questione, una Saab 900 Turbo, assume agli occhi di Yusuke la valenza di un oggetto feticcio, capace di mascherare la perdita della persona amata, annullare l’angoscia della morte, immobilizzare il tempo (al volante dell’automobile, l’uomo ha l’abitudine di ascoltare la registrazione su cassetta della voce di Oto, un rituale che gli consente di perpetuare il ricordo ossessivo della persona scomparsa).
Misaki, essa pure un’anima lacerata, afflitta dai fantasmi di un passato doloroso, gravato da oscuri sensi di colpa, si rivela una figura femminile benevola, capace di restituire all’eroe la serenità di cui era privato. Superate le diffidenze iniziali, i due stabiliscono a poco a poco un rapporto di complicità, da cui è esente ogni connotazione sentimentale o erotica. La rieducazione alla vita, in Yusuke, potrà passare così attraverso un percorso di apertura e conoscenza di sé e degli altri (“Per vedere e capire gli altri bisogna scavare dentro se stessi”, dice un personaggio del film). L’uomo sarà indotto a far emergere il non detto del suo rapporto con Oto e a confrontare la propria sofferenza con quella della sua giovane autista. Di qui la decisione di compiere un viaggio sui luoghi della memoria di Misaki, là dove la ragazza ha vissuto il suo dramma personale. E questo per consentirle di liberarsi dei sensi di colpa che la perseguitano e placare il suo dolore.
Al completamento del lavoro sul lutto corrisponde, in Yusuke, la riscoperta della propria attività creativa come attore (la scelta di recitare lui stesso il ruolo di Zio Vanja).
Il film è di una precisione e di una limpidezza cristalline. Ryusuke Hamagushi si affida a una scrittura larga, meticolosa, pausata, che gli consente di prendersi tutto il tempo necessario per scandagliare l’anima dei personaggi, sia quelli principali che quelli di secondo piano. La vicenda imbocca talora percorsi imprevedibili, forse non sempre giustificati (l’incapacità dell’attore giovane, che era stato amante di Oto, di contenere le proprie pulsioni violente), ma conserva costantemente, nei suoi quasi 180 minuti, una densità e una fluidità rare e ammirevoli.
Siamo di fronte a un autore ancora “giovane” (pochi i film sinora realizzati, tra cui il delizioso Il gioco del destino e della fantasia, premiato nel 2021 al festival di Berlino), ma già pienamente maturo.
Nicola Rossello