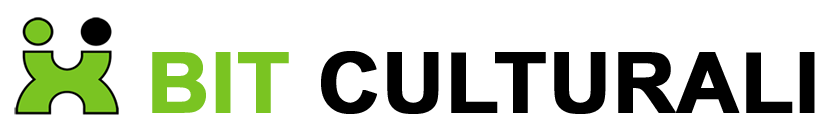Realizzato nel 1937, L’angelo del focolare raffigura una creatura dalle sembianze mostruose, coperta di stracci multicolori, che sembra voler uscire dalla cornice del dipinto e precipitarsi su di noi: un’immagine terrificante, sorta di sinistra prefigurazione degli orrori di quella guerra che di lì a poco verrà a sconvolgere il mondo e la vita stessa di Max Ernst. (Internato nel 1939 in un campo per stranieri in Francia, liberato su pressione dell’amico Paul Eluard, poi l’anno successivo nuovamente internato, Ernst riuscirà infine a fuggire e a riparare in America grazie all’aiuto di Peggy Guggenheim).
L’angelo del focolare è stato scelto come immagine guida della rassegna aperta a Palazzo Reale a Milano fino al 26 febbraio 2023 e curata da Martina Mazzotta e Jürgen Peck.
La mostra allinea un nutrito numero di opere tra dipinti (un’ottantina), sculture, collages, disegni, fotografie, argenti e libri, individuando nel percorso biografico e di ricerca di Ernst (che fu, oltre che un protagonista della pittura del Novecento, un intellettuale raffinato, i cui interessi spaziavano dalla filosofia all’alchimia, dalla letteratura alle scienze naturali, all’antropologia) quattro tempi distinti: il tempo della formazione e del confronto con le avanguardie storiche del primo Novecento (di particolare rilevanza la fase dadaista); la grande stagione parigina e dell’adesione al Surrealismo; gli anni dell’esilio in America e della definitiva consacrazione (1941-1953); il periodo conclusivo, successivo al ritorno di Ernst in Europa. (Va precisato però che l’esposizione non segue un rigido percorso diacronico, ma si organizza piuttosto lungo sezioni tematiche e confronti).
Quella che si offre allo spettatore è una produzione nutrita di simboli di derivazione freudiana; un universo fantastico di grande originalità su cui dominano atmosfere ambigue, governate dalla logica del sogno e dalle pulsioni inventive dell’inconscio, dove, venuto meno il confine tra mondo interiore e realtà esteriore, figure dall’aspetto ibrido, oggetti enigmatici, attraverso accostamenti e montaggi non congruenti, acquistano significati nuovi, misteriosi, spaesanti, risonanze arcane. Opere in cui il dialogo ironico con l’antico (Pietà o La rivoluzione della notte, Londra, Tate Gallery, un omaggio-dissacrazione, coniugato al maschile, al capolavoro di Michelangelo) convive con l’attenzione verso i fermenti dell’arte contemporanea (Edipus Rex, il cui straniante spiazzamento prospettico è memore del de Chirico ferrarese; La festa a Saillans, Parigi, Centre Pompidou, dove pare di poter cogliere un’eco delle gioiose cromie mediterranee di Matisse). Tele in cui è possibile individuare temi, simboli, figure del vocabolario iconografico dell’artista, motivi ossessivi propri del suo personale repertorio visivo: l’uccello, capace, come scrive Giuseppe Gatt, di restare “incontaminato nella sua purezza nonostante la corruzione fisica dei corpi e morale delle anime” (Monumento agli uccelli, Marsiglia, Musée Cantini; Un tessuto di menzogne, Parigi, Centre Pompidou); la foresta, ovvero il paesaggio notturno, allucinato, spettrale, che emerge dall’inconscio e dall’esplorazione dei ricordi dell’infanzia (La foresta, Venezia, Collezione Guggenheim; Foresta e colomba, Londra, Tate Gallery; La natura all’aurora, Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea).
Il visionarismo di Ernst si muove all’interno dell’immaginario surrealista. E però, come ha ben notato Werner Spies, nelle mani del maestro, “il capriccio, il grottesco, il sillogismo assumono una forma inimitabilmente personale e inconfondibile”. La specificità del linguaggio ernstiano si misura anche dal peso maggiore che, rispetto ai sodali del Surrealismo, Ernst accorda alla sperimentazione delle tecniche più diverse: dalla decalcomania al frottage (lo sfregamento del colore sul legno o sulla pietra: “questo procedimento”, precisava l’autore, “non è altro che l’equivalente di una sorta di scrittura automatica”), dal grattage al dripping. Una tecnica, quest’ultima, lo “sgocciolamento”, da cui Ernst prese presto le distanze (“Un gioco da ragazzi”, così lui la definiva, “che molti pittori a New York adottarono facendone abbondante uso. Specialmente Jackson Pollock, soprannominato dai suoi amici ‘Jack lo sgocciolatore’”), a riprova dell’ostilità con cui il maestro accolse negli ultimi anni della sua vita le nuove tendenze dell’espressionismo astratto e dell’informale.
Nicola Rossello