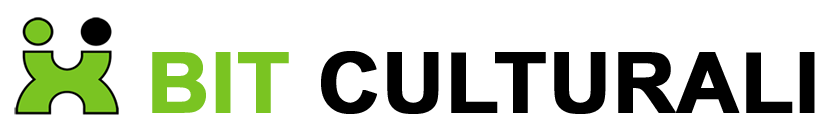La piena consapevolezza critica dell’altissima levatura artistica di Giacomo Ceruti (1698-1767) è un fatto relativamente recente: risale alla prima metà del secolo scorso e la si deve in larga misura all’intuito di Giuseppe Delogu e Roberto Longhi. Fu proprio Longhi a individuare nell’opera del Pitocchetto (così fu soprannominato Ceruti per i soggetti di basso ceto da lui dipinti) il tratto conclusivo di quella linea lombarda di “pittura della realtà” di matrice foppesca che aveva avuto in Romanino, Savoldo, Moretto, Moroni, Ceresa, Fra’ Galgario e, appunto, Ceruti, i suoi esponenti più rappresentativi. Una pittura di austera evidenza documentaria e di “serio impegno di naturalezza”, votata a un realismo fortemente mimetico, che si era sviluppata soprattutto nel territorio compreso tra Bergamo e Brescia, città allora soggette al governo della Serenissima.
E Brescia, dove già nel 1999 si era svolta una splendida rassegna sull’immagine dei pitocchi nella pittura italiana, ospita sino al 28 maggio 2023, presso il Museo di Santa Giulia, la mostra “Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento“. Gli ordinatori dell’esposizione, Roberta D’Adda, Francesco Frangi e Alessandro Morandotti, con scelta accorta, hanno inteso dare adeguato risalto anche alla produzione meno nota e meno celebrata del maestro – ché Ceruti fu artista di ricca e inquieta versatilità, capace di assimilare e rielaborare i mutamenti di gusto e le novità pittoriche e culturali del suo tempo. Nondimeno, essi non hanno trascurato la fase stilistica più alta e intensa e riconoscibile della carriera del Pitocchetto, quella corrispondente al suo lungo soggiorno nella città lombarda (1721-1733) e alla serie di capolavori di soggetto popolare.
Quadri spesso di dimensioni monumentali (le stesse che in genere venivano riservate alle grandi pale d’altare o ai ritratti di personaggi d’alto rango), in cui predomina una tessitura cromatica di sobria, “bassa” intensità, ridotta ai toni del nero, del bruno, del grigio, del cachi, del bianco sporco, ci consegnano il mondo del popolo minuto e dei reietti: un campionario di un’umanità anonima e derelitta, confinata entro scenari desolati: mendicanti, storpi, nani, vagabondi coperti di stracci e segnati dagli stenti, bambini laceri, vecchi, donne consumate dalla fatica, umili artigiani intenti al proprio lavoro: figure tutte restituite nella loro rassegnata miseria e dolente umanità da una pittura solidare, compassionevole, partecipe, ignara sicuramente (ed è questo l’elemento di maggior novità rispetto alla produzione di quanti anche in passato si erano cimentati con il genere popolaresco), ignara di ogni intenzione derisoria o caricaturale (si pensi, per contro, alla sequela delle “bambocciate” del Seicento), come di ogni compiaciuta indulgenza verso il patetico o il sentimentalismo di maniera.
Le tele che compongono lo strepitoso Ciclo di Padernello (qui ricomposto quasi per intero), quadri come Due pitocchi, La lavandaia, Incontro nel bosco o Ritratto di giovane col ventaglio, che in mostra sono messi a confronto con le scene di vita popolare di Monsù Bernardo o del Todeschini, hanno indotto gli studiosi a interrogarsi sui rapporti tra l’artista e i suoi committenti (tra questi ultimi, le famiglie più in vista di Brescia: gli Avogadro, i Fenaroli, i Lechi, i Barbisoni), rapporti in cui entrano in gioco, forse, le prime avvisaglie del nuovo spirito illuminista lombardo; di certo, una sensibilità cristiana profonda e intensamente vissuta, che induceva a guardare con sguardo caritatevole alle misere condizioni di vita delle classi più umili.
Negli anni in cui fu attivo a Brescia, Ceruti raffigurò la nobiltà locale in un nutrito gruppo di ritratti dove pure impera lo stesso sapore di forte verità, di immediatezza e asciuttezza realistica e penetrante attenzione dei suoi dipinti dedicati ai pitocchi. Collocati entro fondali neutri, uniformi, privi di minuzie descrittive d’ambiente, l’Abate Angelo Lechi, il Frate cappuccino col Crocefisso, l’Ecclesiastico seduto sono colti in pose dimesse (il richiamo al modello del ritratto “al naturale” di Moroni è palese, così come le affinità con Ceresa e Fra’ Galgario), e ciò consente all’artista di imbastire “un dialogo senza distrazioni con il modello, finalizzato a rivelarne le inclinazioni più sincere” (Francesco Frangi).
Notevole il divario con la produzione ritrattistica negli anni successivi al suo allontanamento da Brescia (una fuga dovuta, pare, alla necessità di sottrarsi ai creditori…). A Venezia e poi a Milano e a Piacenza, Ceruti entrerà in contatto con le più aggiornate tendenze pittoriche del momento, dove il nuovo gusto rococò andava progressivamente soppiantando quello barocco, e con una committenza di cultura internazionale; fattori entrambi che, inevitabilmente, avrebbero condizionato le scelte iconografiche e stilistiche dell’artista. Il Pitocchetto si adegua alle più moderne convenzioni della ritrattistica ufficiale, conferendo ai suoi dipinti un’intenzione celebrativa (si pensi al Ritratto di violoncellista). I modelli sono ora colti entro cornici ambientali sonanti, tra imponenti colonne e drappi agitati dal vento. Le loro posture acquistano una maggiore animazione; la tavolozza tonalità più ricche e preziose, memori dei valori coloristici e luminosi della scuola veneziana.
La seconda stagione di Ceruti comporta una decisa sterzata stilistica, l’adozione di un linguaggio pittorico nuovo, più dinamico, in contrasto con l’ispirazione primigenia dell’artista. Le stesse opere pauperistiche possono ora vantare un più studiato taglio impaginativo e una qualità luministica inedita, lontana dalle gamme soffocate del passato (Filatrice e pastore con gerla). Il Pitocchetto è indotto altresì a rinnovare e ad arricchire il proprio repertorio e a misurarsi con modelli di genere, temi e soggetti per lui insoliti: il quadro mitologico, la scena pastorale, il ritratto equestre, la natura morta, la testa di carattere, la scena di costume orientale.
Su questa seconda fase di Ceruti si sono addensati i giudizi più disparati. Se chi, come Claudio Pescio, pur senza ravvisare nel nuovo indirizzo del maestro un ripiegamento involutivo, lamenta “un’evidente attenuazione della portata sociale delle sue creazioni”, Mina Gregori, autrice di una fondamentale monografia sul Pitocchetto, parla di lui come del “pittore più avventuroso del Settecento italiano”, ponendo l’accento sul rinnovamento linguistico degli ultimi decenni e sull’apertura alle sollecitazioni della pittura veneta e francese.
Si consideri allora l’àmbito della pittura sacra, a cui pure Ceruti attese in tempi diversi (il Museo diocesano di Brescia, dove è in corso una sorta di appendice alla mostra di Santa Giulia, ospita in questi giorni un certo numero di opere di carattere religioso sue e di altri pittori attivi nel territorio bresciano e bergamasco nel primo Settecento), e si pongano a confronto, a giustificare i punti di merito del Pitocchetto dell’età matura, le prove ancora impacciate da lui fornite per le parrocchiali e le piccole comunità della Val Camonica con la Madonna col Bambino con santi Lucia e Rocco della chiesa del Corpus Domini a Padova, una superba pala d’altare dalle squillanti cromie tiepolesche. Un’opera che arriva a farci intendere come tra Tiepolo e Ceruti, due personalità per tanti versi antitetiche nel panorama della pittura italiana del Settecento, le distanze non siano sempre state così incommensurabili.
Nicola Rossello