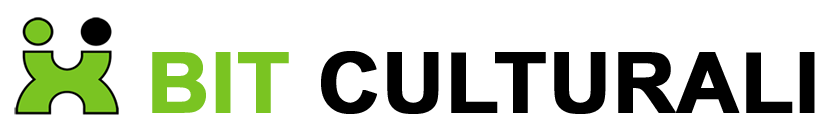La rassegna che nel 1990 si tenne nel capoluogo lombardo intitolata “Morandi e Milano” mirava a documentare il profondo legame tra la città meneghina e il maestro bolognese. Milanesi, o comunque lombardi, furono i primi importanti collezionisti di Giorgio Morandi. Milanese la Galleria del Milione, che si impegnò a far conoscere e valorizzare le sue opere. A Milano, per i tipi della Hoepli, venne pubblicata nel 1939 la prima monografia sull’artista (scritta da Arnoldo Beccaria).
Sono passati più di trent’anni da quell’evento e Morandi torna ora a Palazzo Reale con una ricca retrospettiva (aperta sino al 4 febbraio 2024) che ci consente di ripercorrere la sua lunga carriera, le tappe successive di un’attività artistica durata mezzo secolo, dalle prime prove giovanili del 1913, ancorate al clima delle avanguardie storiche che si respirava allora in Europa, fino agli ultimi lavori del 1963, un anno prima della morte del maestro. Il proposito della curatrice Maria Cristina Bandera è quello di dare conto al visitatore dell’evoluzione nel tempo del linguaggio figurativo di Morandi, così come essa emerge nei generi che egli frequentò con maggiore insistenza – la natura morta, soprattutto, e il paesaggio –, generi che divennero presto la cifra stilistica dell’artista, contribuendo a diffondere la sua fama nel mondo.
L’esposizione, che segue un andamento cronologico, si compone di circa 120 opere (oli, acquerelli, acqueforti), suddivise in 34 sezioni. Le prime delle quali sono dedicate, appunto, ai rapporti tra il giovane Morandi – un Morandi ancora in cerca della propria strada – e i nuovi approcci stilistici che si andavano diffondendo in Italia negli anni che precedettero la Grande Guerra. La conoscenza di Cézanne e delle sperimentazioni fauves e cubiste, i contatti con i futuristi (con i quali Morandi espone nel 1914) diventano per il maestro emiliano occasioni per saggiare la propria voce, mettere a punto una personale visione antinaturalistica della realtà.
Alla vicinanza, a partire del 1918, con il moto metafisico e al successivo accostamento al gruppo della rivista “Valori Plastici” vanno ricondotti i primi indiscussi capolavori. In mostra sono presenti alcune Nature morte “metafisiche” di straordinaria qualità: una custodita nella Fondazione Magnani-Rocca e due conservate a Milano, una a Brera (proveniente dalla collezione Jesi), l’altra al Museo del 900 (già nella collezione Jucker): splendidi dipinti che, allineandosi alle ricerche che in quegli anni andavano conducendo De Chirico e Carrà, calano gli oggetti rappresentati – manichini, squadre, bottiglie – entro una realtà altra, ambigua, sottratta alle contingenze dello spazio e del tempo. A differenza, però, di quanto avveniva in De Chirico, qui non è l’aspetto enigmatico e ironico, il senso di straniato stupore che nasce dall’accostamento di elementi incongrui, a interessare il pittore, bensì lo studio dell’oggetto in se stesso, la limpida geometria della sua forma, la sua immobilità, la rigorosa definizione dei rapporti spaziali.
Superato il periodo metafisico, Morandi sul finire degli anni Venti, quelli della sua piena maturazione artistica, perviene a una pittura più castigata e austera, che però, nella riproposta quasi esclusiva dei soggetti prediletti, conserva una sostanziale coerenza con la produzione precedente. Assertore dell’uso costante, in pittura, della ripetizione (meglio: della variazione all’interno di opere di simile soggetto), Morandi concentra la propria ricerca sulla natura morta, genere nel quale egli è sempre stato particolarmente prolifico. Motivi ricorrenti dei suoi dipinti saranno allora oggetti umili e banali, di uso quotidiano: bottiglie dal collo lungo, brocche, fruttiere, caraffe, tazze, bicchieri, lumi a petrolio, vasi di fiori, sottratti a ogni eloquenza decorativa, accostati secondo rigorose regole compositive e studiate armonie di toni, restituiti con una gamma cromatica molto ridotta, nella quale predominano i colori opachi, i grigi e i bruni, in particolare. Tra le Nature morte esposte in mostra, emergono (ma il giudizio è squisitamente soggettivo) quelle in arrivo dal MART di Rovereto, dalla collezione ENI, dalla Galleria d’Arte Moderna di Milano, i Fiori della Fondazione Roberto Longhi di Firenze e quelli di una collezione privata di Varese: immagini tutte di profonda sensibilità compositiva, che esibiscono un’impaginazione severa, ascetica, cercata ma non ricercata (gli oggetti, rappresentati nella loro disadorna essenzialità, rinunciano all’esatta definizione dei contorni e tendono a sfumare nell’ambiente). Immagini che, nell’ultimo Morandi, quello degli anni Cinquanta e Sessanta, assumono strutture sempre più rarefatte, evanescenti, incerte, ai limiti dell’astrazione formale (le Nature morte provenienti da Siegen, da Vevey, da Winterthur…). Accanto alle nature morte, i meno frequenti “paesaggi inameni” (così li definiva Roberto Longhi), che ritraggono, senza indugi descrittivi o panoramici, le colline emiliane, gli scorci anonimi di Grizzana, il paesetto dell’Appennino bolognese dove Morandi trascorreva le sue estati (in mostra, tra gli altri, il Paesaggio della GAM di Torino e quello della Camera dei Deputati di Roma).
Nonostante il suo talento fosse universalmente riconosciuto e celebrato (i maggiori studiosi del tempo, da Roberto Longhi a Cesare Brandi, da Lionello Venturi a Francesco Arcangeli, non tardarono a individuare in lui una personalità artistica di altissimo livello), Morandi rimase per tutta la vita un pittore appartato, accompagnato dalla fama di personaggio schivo, ben deciso a coltivare la propria altèra solitudine e il proprio indiviso rigore morale (“il monaco Morandi”, lo definiva Longhi). Poche le sue frequentazioni, pochissimi i suoi viaggi (non si è quasi mai mosso da Bologna per l’intera durata della sua carriera; ma si ricorda una sua scappata a Firenze, nel 1910, che gli diede modo di conoscere la pittura di Giotto, Masaccio, Paolo Uccello: i suoi “antichi maestri”). Egli scelse di far parte a se stesso e di condurre una vita ritirata e laboriosa nella quiete del suo studio bolognese, lontano dal chiasso delle folle e dai cenacoli mondani dove si pontificava sulle sorti dell’arte contemporanea. Una scelta di aristocratica, orgogliosa indipendenza, la sua, che ha saputo dare i suoi buoni frutti.
Nicola Rossello